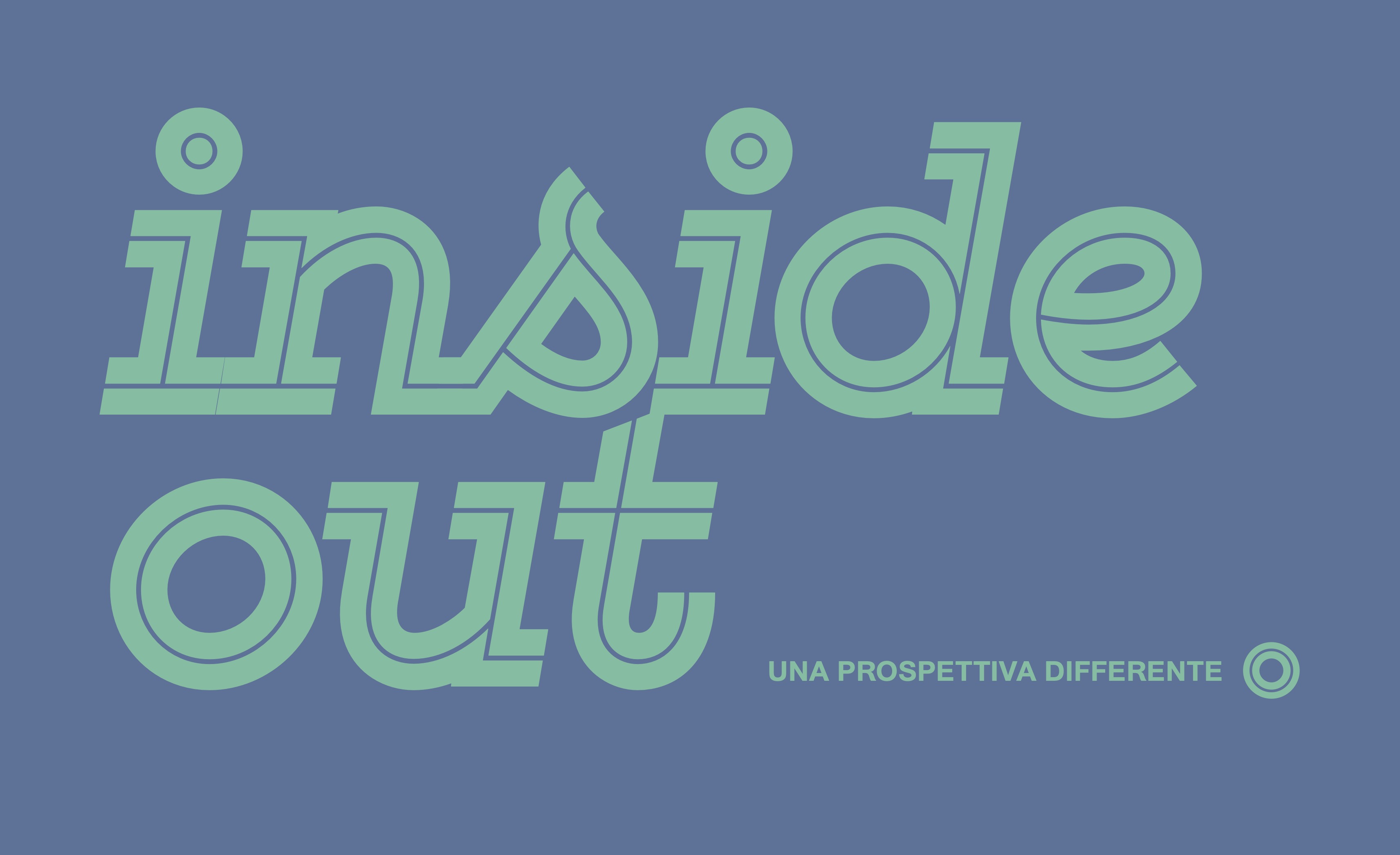Jacopo Rampini ci racconta cosa significa crescere e formarsi all’estero e come ha costruito la propria carriera di attore tra gli Stati Uniti e la nostra penisola. Tornato da poco in Italia, riflette sulle differenze culturali legate al mondo del lavoro tra i due paesi.
Anagraficamente, Jacopo Rampini di italiano ha il nome, il luogo di nascita (Roma, 17 agosto 1986) e poco altro. Madrelingua inglese e francese, l’essere in continuo movimento è per lui una condizione naturale: la professione del padre Federico Rampini, uno dei più importanti giornalisti italiani (corrispondente, negli anni, da Bruxelles, San Francisco, Pechino e New York, attualmente editorialista per Il Corriere della Sera) lo ha portato, fin dalla nascita, a vivere, crescere e formarsi in moltissime città e Paesi diversi, per poi finire a New York. Ci è arrivato appena ventenne, nei primi anni duemila: sarà poi lì che, per oltre 15 anni, si fermerà, costruendo, da zero, la propria carriera di attore. Ora vive tra New York e l’Italia, dove recita a teatro, in televisione e nel cinema indipendente. Per questa intervista ci incrociamo a Milano.
 Il tuo è un curriculum decisamente internazionale, e lo è da subito: nasci a Roma ma di fatto vivi all’estero fin dai tuoi primi mesi di vita.
Il tuo è un curriculum decisamente internazionale, e lo è da subito: nasci a Roma ma di fatto vivi all’estero fin dai tuoi primi mesi di vita.
Sì, esatto. Quando avevo un mese i miei genitori mi hanno portato a Parigi, perché mio padre, all’epoca, era corrispondente tra Parigi e Bruxelles. Sono cresciuto bilingue: frequentavo la scuola materna francese mentre a casa parlavo italiano. Non sono poi più tornato in Italia fino ai miei sei anni. Ero sicuramente molto piccolo, posso dire però che già quei primi anni mi hanno reso, di fatto, poco italiano. Mio padre è di Genova, mia madre di Roma ma sono entrambi cresciuti a Bruxelles; anche loro, quindi, parlavano già francese. Dopo Parigi, c’è stata una parentesi di sette anni a Milano, dove ho frequentato le scuole francesi. Arrivo, poi, da adolescente a San Francisco e qui trascorro gli anni del liceo, imparando l’inglese da madrelingua. Sono riuscito a ottenere i documenti per risiedere negli Stati Uniti, decidendo quindi di vivere la mia vita lì e non in Europa. Ho studiato Lettere e Filosofia alla Sorbona di Parigi, prima di trasferirmi a New York nel 2008 e lavorare in una casa editrice.
A questo proposito: al tuo arrivo a New York, di fatto non avevi in mente di fare l’attore.
No, esatto. La recitazione però mi aveva sempre incuriosito: avevo frequentato un primo corso di formazione a San Francisco, all’American Conservatory Theater, quando avevo circa 15 anni. Mi ricordo che però ai tempi parlavo ancora pochissimo inglese; perciò, recitare in una lingua che non era la mia era molto complicato. Quindi, dopo aver imparato bene l’inglese, e dopo la laurea alla Sorbona, mi trasferisco a New York per questa casa editrice. Dopo qualche mese, però, arriva la crisi del 2008 e mi licenziano: io e altre 15 persone ci troviamo senza lavoro. Mi sono detto: “Ok, ho 21 anni, sono a New York, perché non colgo questa occasione per provare a fare qualcosa che mi piace?”. Faccio un provino per la American Academy of Dramatic Arts, che è una delle più antiche scuole americane, dove hanno studiato nomi come Robert Redford, Danny De Vito, Lauren Bacall. Ottengo una borsa di studio per il primo anno. Da lì, ho cominciato un percorso di due anni di formazione, soprattutto teatro: in America ti formano anche per fare i musical, quindi ho studiato anche voce, danza e canto. Frequentavo l’accademia full-time dalle 9 del mattino alle 6 del pomeriggio: lì ho scoperto la mia vera vocazione.
Dopo la formazione inizi quasi subito a lavorare a New York in teatro, in tv e al cinema. Reciti in alcune importanti serie tv, tra cui Law & Order, FBI per CBS, Halston con Ewan McGregor. Ci racconti che aria si respira a New York in questo settore, come ti sei mosso, qual è stata la tua esperienza nei primissimi anni?
Il mio primo lavoro importante è stato quello di interpretare il ruolo del giovane Stalin (nella serie World Wars, per History Channel, ndr). La storia di come ho ottenuto quel ruolo è interessante. Lì funziona che se frequenti la Juilliard School o la Yale School of Drama gli agenti spesso ti ingaggiano quando sei ancora a scuola; diversamente, come nel mio caso, quando esci dall’accademia comincia un lavoro pazzesco per trovarti un’agenzia, che è molto complicato: quando inizi non hai chiaramente nessun lavoro, quindi perché un agente dovrebbe investire su di te? Un mio amico mi disse: “Stanno facendo dei provini per una serie storica e cercano il giovane Stalin, ho visto la foto e sei uguale”. Guardo la foto di Stalin da giovane e in effetti ero molto simile…(ride). Il provino per questa serie era “aperto”, cioè si trovava su uno di questi siti in cui semplicemente puoi provare a mandare la tua application. Faccio il primo provino e mi richiamano. Poi una seconda volta, poi una terza… Alla fine mi presero. Non era una grande produzione, di certo non una serie di HBO, però ha avuto molto successo e da lì sono riuscito a trovarmi un agente che ha iniziato a propormi lavori. Per il resto, ci sono alcune serie molto newyorkesi, tipo Law & Order, che girano da vent’anni nella city: prima o poi quindi è abbastanza facile che ti ritrovi a farci un provino. Sono serie che ti danno sicuramente molta visibilità, ma sono anche una bella esperienza professionale: quelle produzioni sono delle macchine, hanno scadenze molto strette entro le quali devono produrre tanto. Si gira una cosa oggi, nell’arco di due settimane è già pronta, e la settimana dopo esce in televisione. È veramente una catena di montaggio.
Tu hai vissuto la pandemia a New York. Una situazione molto complessa per tutti dal punto di vista lavorativo, immagino ancora di più per un settore come il tuo dove tutte le produzioni si sono bloccate per diversi mesi. Come hai vissuto quel periodo e com’era New York nei mesi della pandemia?
La pandemia è stata terribile ovunque, ogni Paese ha avuto le sue difficoltà. A noi non hanno mai chiuso in casa, potevamo sempre uscire a camminare. Quello che è stato piuttosto pesante per chi viveva a New York in quel periodo sono stati i movimenti di Black Lives Matter, che si sono scatenati dopo l’omicidio di George Floyd e che sono andati in parallelo con le correnti che intendevano destrutturare e togliere fondi alla polizia (con lo slogan “Defund The Police”, ndr). New York in quei mesi è tornata un po’ come la descrivevano negli anni Settanta – Ottanta: il tasso di criminalità era cresciuto a livello esponenziale e la polizia, delegittimata dall’opinione pubblica e di fatto molto ridotta nel numero degli agenti, non riusciva a gestire quanto succedeva all’ordine del giorno. Ho visto una città trasformata e molto ostile. Anche lavorativamente la situazione era molto complessa. In America esistono le cosiddette Unions, e quando diventi un attore professionista entri a far parte di SAG-AFTRA (acronimo di Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, ndr). Queste organizzazioni, con il Covid, avevano necessità di trovare un accordo tra le varie produzioni e le assicurazioni, in primis sanitarie, prima di consentire ad attori e registi di tornare sul set. È stato complesso arrivare al COVID-19 Safety Agreement, perciò è rimasto tutto fermo per diversi mesi. Parallelamente, io avevo avuto la fortuna di essere stato preso, appena prima della pandemia, per una serie Netflix, Halston, con Ewan McGregor. Con il Covid si era ovviamente fermato tutto, sono arrivato a pensare “ok, non si farà mai più”. A ottobre 2020 invece mi richiamano. Era una parte minuscola la mia, ma avevano deciso di tenerla.
Nel 2021 partecipi ad un progetto internazionale girato tra Italia, Spagna e Marocco, la serie spaghetti western That Dirty Black Bag firmata dal giovane regista Mauro Aragoni, classe 1988, con diversi attori italiani, inglesi, americani, australiani.
Per me è stata un’esperienza unica dal punto di vista professionale perché era un periodo in cui non stava lavorando nessuno. Non solo, ma quest’occasione mi ha consentito di riprendere a viaggiare in piena pandemia. Mi ricordo quando, in pieno Covid, presi questo volo New York-Roma: l’aereo era completamente vuoto, a bordo c’era solo l’equipaggio. Dovevamo girare in Puglia: c’erano ancora i vari lockdown, di fatto non si poteva uscire dall’hotel. Poi arrivavi sul set dove improvvisamente trovavi un’atmosfera magica, vita, fermento: un’esperienza incredibile. Mi sono innamorato del progetto: un giovane regista italiano che è riuscito a vendere, partendo da un cortometraggio, una serie spaghetti western – un genere sicuramente un po’ a parte – a una produzione molto importante, la Palomar. È stata forse l’esperienza lavorativa più bella della mia carriera: anche se avevo un ruolo piccolo, per me ha rappresentato la fine della pandemia, il ritorno al lavoro e alla vita.
Un messaggio incoraggiante per l’Italia: un po’ un unicum all’interno delle produzioni italiane.
Vedevo questo ragazzo giovane, il regista, su un set enorme con attori stranieri provenienti da tutto il mondo. Io, che ero nella prima fase di elaborazione di una mia serie televisiva, ho visto la possibilità di realizzarla: da lì mi sono rimesso al lavoro, rimaneggiando un’idea originale di qualche tempo prima, rilanciandomi nella possibilità di venderla, cercando produttori, proprio con l’iniezione di ottimismo e positività derivata da questa esperienza. Mi sono detto: se questo ragazzo sardo di 25 anni l’ha fatto, ci posso riuscire anche io.
Questa serie ti ha fatto rientrare in Italia dopo 15 anni negli Stati Uniti. Come ti stai trovando lavorativamente parlando? Roma è, di fatto, il centro nevralgico del cinema italiano. Che aria si respira e cosa evidenzi in questo momento?
Lo sto ancora scoprendo. Ho trascorso gli ultimi sei mesi a Roma e sto ancora imparando a conoscere la situazione attuale delle varie produzioni. Sicuramente, le grandi piattaforme si sono ormai stabilite: Netflix, Amazon Prime, Paramount. In parallelo, molte produzioni americane stanno girando in Italia, penso per esempio a serie come The White Lotus o Succession. Ci sono senz’altro opportunità che magari 10 o 20 anni fa mancavano. Sto cercando di capire quanto siano per me sfruttabili, anche in base ai trend di mercato in questo momento: quali siano cioè le opportunità per un attore, di fatto, americano – mi considero tale perché ho fatto tutta la mia formazione in America, sono cresciuto là – che torna in Italia.
Si parla molto spesso, in maniera anche un po’ retorica, degli Stati Uniti come “the land of opportunities”. Un clichè che ha diverse sfaccettature, come il mito della meritocrazia. Quanto c’è di vero e di reale?
Ci stavo pensando proprio in questi giorni: sono tornato da poco dagli Stati Uniti dove ho fatto una piccola parte in una serie televisiva, ho passato un mese lì e mi è sembrata sempre più netta la spaccatura culturale tra Italia e USA, la forte differenza di mentalità. Il cosiddetto “sogno americano” è una chimera, strutturata come tale, però di fatto la gente ci crede. Se tu in Italia dici “io voglio vincere un Oscar, o un David di Donatello” la gente ti guarda sorridendo. In America, all’opposto, c’è questo approccio ottimistico a prescindere, realmente naif, che qui viene percepito come qualcosa di finto o stupido. La risposta lì è, più o meno per qualsiasi cosa, “Lo puoi fare!”. Culturalmente noi in Europa siamo molto cinici, ma l’atteggiamento americano, che si riflette anche nel clima positivo e intrinsecamente fiducioso che si respira nella vita di tutti i giorni, ecco, quella cosa lì ti aiuta. Molto. Io penso di esserne la prova vivente, nel senso che arrivai a New York con una laurea in Lettere e Filosofia, mandai un CV a una casa editrice, mi presero. Dopo tre mesi mi assunsero, semplicemente con l’idea di “dare una chance a questo ragazzo che si sta impegnando”. Avevo l’ufficio nel Flatiron Building. Avevo 20 anni: da piccolo avevo un poster di quel palazzo a casa mia, adesso ci lavoravo dentro. Più sogno americano di così… Purtroppo, ogni volta che torno in Italia, trovo che questa mentalità viene vista con molto scetticismo. Dall’altro lato, quell’ingenuità sfrontata, all’americana, secondo me alla fine ti porta un po’ più avanti.
Spesso, quando parlo con italiani trasferiti all’estero, mi evidenziano un fenomeno tipico degli expat, quello cioè della difficoltà a tessere relazioni profonde, a mettere vere radici, a fronte però di maggiori soddisfazioni dal punto di vista lavorativo ed economico. Si tratta di una sorta di “give & take”.
È vera questa cosa sui rapporti personali. Forse però bisogna differenziare, nel senso che io vivevo a New York che non si può considerare tanto America, è un po’ qualcosa a sé. È vero che è una città molto business, l’approccio è “se mi servi per qualcosa rimaniamo in contatto altrimenti no”, però trovo che sia abbastanza dichiarata questa cosa, di fatto non è che poi ci rimani male: si sa che è così. D’altro canto, in Italia ho amici di più vecchia data e quindi è naturale avere legami più forti. Va anche detto che l’America è di fatto un paese di transito. Anche New York stessa è una città dove la gente ci passa qualche anno e poi se ne va da qualche altra parte. Mi sento di dire che questa cosa è proprio nella natura stessa dell’essere americani: culturalmente i legami veri, per come li intendiamo noi, sono un po’ più difficili da stabilire rispetto, per esempio, a un posto come Milano, dove io quando torno ritrovo amici che sono rimasti qui dalle scuole medie, alcuni addirittura vivono nella stessa casa dove vivevano all’epoca, o magari nello stesso quartiere.
Le differenze strutturali nell’impostazione del lavoro tra USA e Italia sono molte. Negli Stati Uniti il mercato è molto più fluido, per l’impostazione che abbiamo noi è piuttosto difficoltoso passare da una professione all’altra. Quali sono gli approcci che più vedi diversi in Italia rispetto agli USA e viceversa?
Mi ricollego all’esperienza di cui ti parlavo prima, del lavoro in quella casa editrice. È vero, mi hanno assunto dopo 3 mesi di stage, però poi mi hanno licenziato dopo 8. C’è questa mobilità intrinseca per cui, lì per lì, ti sembra tutto bellissimo, un sogno, il lavoro nel Flatiron Building, ecc. Dopo 8 mesi, però, sono arrivate le famose “2 weeks notice” (2 settimane di preavviso, ndr) ed ero out. I datori di lavoro lo fanno anche in maniera molto tranquilla e fredda, nel senso che è così. Dopo questo licenziamento, certo, ci ero rimasto male, ma ho trovato subito un altro lavoro e mi sono lanciato in qualcos’altro. È molto più facile essere licenziati ma questo crea, parallelamente, una mobilità e un approccio che ti permette di reinventarti ogni volta da zero, anche a 40 o 50 anni, mentre in Europa e in Italia questo è molto più difficile. Un esempio: mia mamma, in Italia, aveva lavorato in banca, ma aveva un master in lettere. A circa 50 anni si è messa a fare l’insegnante di italiano in America, e ha fatto carriera così: fa tuttora quello, ha insegnato alla scuola delle Nazioni Unite a New York e nei licei di San Francisco.
Nel tuo futuro ti vedi più in America o più in Italia?
È una domanda che mi sto facendo anche io. Mi chiedo se, nel mondo di oggi, sia per forza necessario essere fissi in un certo posto o se si possa essere un po’ nomadi. Certo, non avere radici da nessuna parte comporta sicuramente delle difficoltà, così come stare sempre in movimento, ma io mi sto rendendo conto che essendo cresciuto così mi trovo a mio agio in questa modalità. E non lo dico per essere cool: quando sto fermo troppo a lungo in un posto in realtà non sto bene. Vorrei quindi riuscire a continuare a fare la mia carriera tra gli USA e l’Italia perché credo ci siano ottime potenzialità in entrambi i Paesi. A questo proposito, il progetto più importante che ho in uscita nel 2023 qui in Italia è sicuramente il film Shakespea Re di Napoli, per la regia di Ruggero Cappuccio: è l’adattamento cinematografico di una sua opera teatrale in cui io interpreto il ruolo di William Shakespeare e recito al fianco di Alessandro Preziosi. Si tratta del mio primo ruolo da protagonista in Italia, ne sono molto orgoglioso. Ho poi una piccola parte nella nuova pellicola del maestro Pupi Avati, girata tra Bologna e Roma. Ho poi recitato in Romantiche di Pilar Fogliati, uscito lo scorso febbraio, un’amica con cui sono molto contento di aver lavorato. Progetti indipendenti che considero di qualità.
Vedi quindi buone opportunità al momento nel nostro Paese?
Indubbiamente. Vedo che il mondo del cinema e della televisione italiana si sta aprendo molto a produzioni internazionali, anche perché viceversa vediamo quanto siamo amati e apprezzati all’estero. Quando sei in America e dici che sei italiano c’è sempre una risposta incredibile, anche rispetto alla nostra cultura, alla nostra storia. Dobbiamo però, secondo me, stare al passo con questa sfida: dobbiamo dimostrare, quando gli americani vengono a girare da noi, che abbiamo sia il talento sia le risorse per essere al livello delle cose che fanno loro, perché in questo siamo senz’altro un po’ indietro. Dobbiamo quindi “Step up our game”: mettercela tutta per essere a quel livello anche noi. Abbiamo senz’altro le carte per riuscirci.
* Credits: Sara Montalbano